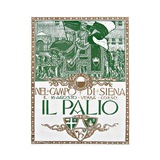Nel 2015, in occasione del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nella Grande Guerra, Massimo Reale, attore e sceneggiatore senese di adozione e ocaiolo, dedicò uno spettacolo teatrale alle lettere e alle parole degli eroi che andavano in guerra.
Oggi è il 24 maggio, e sono 110 anni esatti da quel giorno dell'entrata in guerra dell'Italia.
Su Amazon Prime è disponibile per gli iscritti al servizio il video dello spettacolo di Massimo Reale, Le parole degli eroi.
Oggi è il 24 maggio, e sono 110 anni esatti da quel giorno dell'entrata in guerra dell'Italia.
Su Amazon Prime è disponibile per gli iscritti al servizio il video dello spettacolo di Massimo Reale, Le parole degli eroi.
Primevideo
Watch The heroes' words (Le parole degli eroi) online – Prime Video
Thoughts, emotions, the words of those who lived the drama of the First World War, through the correspondence between soldiers in the trenches and their families anxiously waiting for their return.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Sono state estratte
Lupa
Oca
Bruco
Valdimontone
Pantera
Lupa
Oca
Bruco
Valdimontone
Pantera
Tutte le estrazioni anomale
Come si vede è divenuto piuttosto comune che vi siano estrazioni di più Contrade delle solite tre.
Le estrazioni dal Duemila
È la Nobil Contrada del Bruco ad avere il maggior numero di estrazioni dal Duemila: ben 17, di cui 7 a luglio. Ma nel solo Palio di luglio è la Pantera che è stata estratta per ben 8 volte.
Le vittorie da Contrada estratta
È la Giraffa ad avere il primato delle Vittorie da Contrada estratta dal Duemila, ben 4. Segue il Bruco con 3. C'è anche la Lupa con 2 Vittorie da estratta (tutte ad agosto).
Ma per luglio sono solo Oca e Bruco ad aver vinto da estratte negli anni Duemila.
Come si vede è divenuto piuttosto comune che vi siano estrazioni di più Contrade delle solite tre.
Le estrazioni dal Duemila
È la Nobil Contrada del Bruco ad avere il maggior numero di estrazioni dal Duemila: ben 17, di cui 7 a luglio. Ma nel solo Palio di luglio è la Pantera che è stata estratta per ben 8 volte.
Le vittorie da Contrada estratta
È la Giraffa ad avere il primato delle Vittorie da Contrada estratta dal Duemila, ben 4. Segue il Bruco con 3. C'è anche la Lupa con 2 Vittorie da estratta (tutte ad agosto).
Ma per luglio sono solo Oca e Bruco ad aver vinto da estratte negli anni Duemila.
www.ilpalio.org
Palio di Siena - Estrazioni anomale
Palio di Siena Estrazioni anomale
I Palii delle "Quattro Verdi" al Palio di Siena
Le "quattro verdi" sono le Contrade di Siena che hanno il colore verde tra i loro colori ufficiali: Bruco, Drago, Oca e Selva.
A Siena esiste un detto secondo cui, quando al Palio corrono insieme le "quattro verdi", accadrà una sventura o comunque un episodio destinato a suscitare particolare scalpore. Questa credenza, pur non avendo fondamento statistico-scientifico, è radicata nella tradizione popolare senese e viene tramandata da secoli.
Statistiche e storia
Dal 1723 (anno in cui si cominciò a correre il Palio con dieci Contrade), si hanno notizie certe di 52 Palii delle quattro verdi.
In 22 di questi, la vittoria è andata a una delle quattro verdi (pari al 42,31%), mentre negli altri 30 casi hanno vinto le altre 13 Contrade.
Se guardiamo la devianza statistica, la percentuale del 42,31% è solo di poco superiore alla proporzione di 4 Contrade verdi sulle 10 che corrono (40%).
Tra le "quattro verdi", la Selva è la più vittoriosa con 8 successi, seguita da Oca e Drago (5 vittorie ciascuna) e Bruco (4 vittorie).
Vittorie delle altre Contrade nei Palii delle quattro verdi
Tartuca: 8 vittorie
Chiocciola, Civetta, Giraffa, Lupa: 3 vittorie ciascuna
Istrice, Nicchio, Onda, Valdimontone: 2 vittorie ciascuna
Pantera, Torre: 1 vittoria ciascuna
Aquila, Leocorno: nessuna vittoria
Curiosità
In alcune edizioni (ad esempio agosto 1898 e agosto 2002), Drago o Selva non corsero per infortunio del cavallo, ma questi Palii sono comunque considerati "delle quattro verdi" per la presenza formale delle Contrade.
Gli anni 1989 e 2004 sono gli unici in cui si sono disputati due Palii con tutte e quattro le verdi presenti nello stesso anno.
Il periodo più lungo senza un Palio delle quattro verdi è stato di oltre 22 anni (dal 2 luglio 1855 al 16 agosto 1877).
Attualmente, la "nonna" tra le 4 Verdi è la Nobile Contrada dell'Oca, che non vince un Palio delle 4 Verdi dall'agosto del 1877, quindi non vince da ben 148 anni. Tuttavia questo non è il periodo di maggior digiuno: il maggior periodo senza ottenere vittorie è della Contrada della Selva, la quale non vinse un "Palio delle quattro verdi" tra il 17 agosto 1750 ed il 16 agosto 1919, cioè per 169 anni.
Il mito delle "quattro verdi" è parte integrante della cabala scaramantica paliesca e contribuisce al fascino e al mistero che circonda il Palio di Siena, alimentando racconti, superstizioni e leggende che si tramandano tra i contradaioli.
Quando al Palio corrono insieme le 'quattro verdi', accadrà una qualche sventura o comunque un qualche episodio destinato a suscitare particolare scalpore.
— Tradizione popolare senese
I Palii delle quattro verdi sono eventi rari e carichi di significato nella storia del Palio di Siena, sia per la statistica delle vittorie, sia per il valore simbolico che la città attribuisce a queste coincidenze.
Tutte le info sul sito del Papei
https://www.ilpalio.org/4verdi.htm
#4verdi #quattroverdi
Le "quattro verdi" sono le Contrade di Siena che hanno il colore verde tra i loro colori ufficiali: Bruco, Drago, Oca e Selva.
A Siena esiste un detto secondo cui, quando al Palio corrono insieme le "quattro verdi", accadrà una sventura o comunque un episodio destinato a suscitare particolare scalpore. Questa credenza, pur non avendo fondamento statistico-scientifico, è radicata nella tradizione popolare senese e viene tramandata da secoli.
Statistiche e storia
Dal 1723 (anno in cui si cominciò a correre il Palio con dieci Contrade), si hanno notizie certe di 52 Palii delle quattro verdi.
In 22 di questi, la vittoria è andata a una delle quattro verdi (pari al 42,31%), mentre negli altri 30 casi hanno vinto le altre 13 Contrade.
Se guardiamo la devianza statistica, la percentuale del 42,31% è solo di poco superiore alla proporzione di 4 Contrade verdi sulle 10 che corrono (40%).
Tra le "quattro verdi", la Selva è la più vittoriosa con 8 successi, seguita da Oca e Drago (5 vittorie ciascuna) e Bruco (4 vittorie).
Vittorie delle altre Contrade nei Palii delle quattro verdi
Tartuca: 8 vittorie
Chiocciola, Civetta, Giraffa, Lupa: 3 vittorie ciascuna
Istrice, Nicchio, Onda, Valdimontone: 2 vittorie ciascuna
Pantera, Torre: 1 vittoria ciascuna
Aquila, Leocorno: nessuna vittoria
Curiosità
In alcune edizioni (ad esempio agosto 1898 e agosto 2002), Drago o Selva non corsero per infortunio del cavallo, ma questi Palii sono comunque considerati "delle quattro verdi" per la presenza formale delle Contrade.
Gli anni 1989 e 2004 sono gli unici in cui si sono disputati due Palii con tutte e quattro le verdi presenti nello stesso anno.
Il periodo più lungo senza un Palio delle quattro verdi è stato di oltre 22 anni (dal 2 luglio 1855 al 16 agosto 1877).
Attualmente, la "nonna" tra le 4 Verdi è la Nobile Contrada dell'Oca, che non vince un Palio delle 4 Verdi dall'agosto del 1877, quindi non vince da ben 148 anni. Tuttavia questo non è il periodo di maggior digiuno: il maggior periodo senza ottenere vittorie è della Contrada della Selva, la quale non vinse un "Palio delle quattro verdi" tra il 17 agosto 1750 ed il 16 agosto 1919, cioè per 169 anni.
Il mito delle "quattro verdi" è parte integrante della cabala scaramantica paliesca e contribuisce al fascino e al mistero che circonda il Palio di Siena, alimentando racconti, superstizioni e leggende che si tramandano tra i contradaioli.
Quando al Palio corrono insieme le 'quattro verdi', accadrà una qualche sventura o comunque un qualche episodio destinato a suscitare particolare scalpore.
— Tradizione popolare senese
I Palii delle quattro verdi sono eventi rari e carichi di significato nella storia del Palio di Siena, sia per la statistica delle vittorie, sia per il valore simbolico che la città attribuisce a queste coincidenze.
Tutte le info sul sito del Papei
https://www.ilpalio.org/4verdi.htm
#4verdi #quattroverdi
www.ilpalio.org
I Palii delle "quattro verdi" (Bruco, Drago, Oca, Selva)
I Palii corsi dalle quattro Contrade del Palio di Siena che hanno il colore verde tra i loro colori distintivi. La leggenda vuole che questi Palii siano sventurati!
Previsite al Ceppo il 22, 23 e, se serve, il 24 giugno
Prove Regolamentate (ex Prove di Notte) il 27 e 28, ormai, come divenuta consuetudine, su due giorni.
Ulteriori info per addetti ai lavori tratte da La Voce del Palio
Prove Regolamentate (ex Prove di Notte) il 27 e 28, ormai, come divenuta consuetudine, su due giorni.
Ulteriori info per addetti ai lavori tratte da La Voce del Palio
www.lavocedelpalio.it
Palio 2 luglio 2025: firmata l'ordinanza per preiscrizione alla previsita, prove regolamentate e tratta
E’ stata firmata nella giornata di oggi.
Il Palio Straordinario del 28 maggio 1950 è ricordato come una delle carriere più emozionanti e avvincenti della storia del Palio di Siena. Si svolse in occasione del quinto centenario della canonizzazione di San Bernardino da Siena, una ricorrenza di grande rilevanza per la città, e fu corsa alla presenza del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.
Contesto e organizzazione
Questo Palio Straordinario fu il decimo del Novecento e si caratterizzò per la presenza di dieci Contrade, con un ordine di ingresso tra i canapi determinato da un nuovo meccanismo ideato dall’artigiano senese Luigi Sprugnoli, che garantiva la segretezza dell’ordine fino all’ultimo momento.
Le Contrade al canape
Tra le contrade partecipanti, l’Istrice era considerata la favorita, grazie alla collaudata coppia formata dal fantino Biondo e dal cavallo Popa. La Lupa, tuttavia, non rimase a guardare e organizzò una strategia anti-Istrice coinvolgendo anche altre contrade, mentre cercava la monta adatta per il suo cavallo Salomè.
La sorpresa del Palio fu la Contrada di Valdimontone, che si presentò con il fantino Fernando Leoni, detto Ganascia, e la cavalla Gaia. Nonostante le difficoltà fisiche di Gaia, Ganascia riuscì a portare avanti una corsa astuta e combattuta, giocando d’astuzia fino all’ultimo. Fu probabilmente in quell'occasione che la famosa Stalla del Valdimontone dette la sua prima prova di grande abilità, perché Gaia non era messa per nulla bene.
La Carriera
La partenza vide un gruppo compatto di Onda, Leocorno e Nicchio, che rimasero in testa fino al primo passaggio alla mossa, dove l’Istrice si rivelò fortissima. Il fantino Ciancone, montando per l’Onda, ostacolò ripetutamente Biondo (Istrice), spezzando il ritmo della Popa e permettendo al Nicchio di prendere la testa, seguito dall’Aquila e dal Leocorno, che però caddero entrambe. Quando sembrava che il Nicchio potesse vincere, il suo cavallo Marco Polo I si stancò, e al terzo San Martino si fecero avanti Lupa e Valdimontone, protagoniste di un duello emozionante.
Ganascia, con Gaia ormai stremata, scelse di cadere per giocare l’ultima carta disperata: nella caduta trascinò con sé anche il fantino della Lupa, Tripolino, mentre Salomè si fermò. Gaia, scossa, continuò a correre e vinse, precedendo Ribolla (Leocorno) e l’Istrice, la cui rimonta fu frenata dagli altri cavalli scossi.
Per Ganascia fu l’ottavo e ultimo trionfo nel Palio, conquistato con un capolavoro di astuzia, mentre Tripolino chiuse con malinconia la sua carriera paliesca. Questo Palio è ricordato anche perché stabilì il nuovo meccanismo per l’assegnazione dei posti al canape, ancora oggi in uso.
Palio storico per tanti motivi
- Primo Palio in cui l'ordine di ingresso ai canapi viene determinato con la fiasca meccanica inventata da Luigi Sprugnoli.
- Ultima corsa disputata da Tripoli Torrini, detto Tripolino: nella Lupa.
- Ultima vittoria per Ganascia, che arriva a piedi sotto il palco dei giudici, sarà l'ultima vittoria: infatti Gaia, il cavallo che montava nel Valdimontone, vincerà scossa.
- Per la prima volta si inizia a cronometrare il tempo della corsa, durata un minuto e ventinove secondi.
Curiosità
- Il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi assistette alla corsa, sottolineando l’importanza nazionale dell’evento.
- Il Palio fu dedicato al V centenario della canonizzazione di San Bernardino da Siena.
- Il meccanismo di assegnazione dei posti al canape, introdotto proprio in questa occasione, è ancora oggi utilizzato nei Palii di Siena.
- I contradaioli vittoriosi del Valdimontone vanno a portare il Drappellone nella chiesa di Sant'Elisabetta della Visitazione, perché trovano chiuso l'Oratorio di San Bernardino. Qui dove si andò a festeggiare gli Straordinari dal Novecento in poi.
Il Palio Straordinario del 28 maggio 1950 fu un evento eccezionale, ricco di emozioni, strategie e colpi di scena, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Palio di Siena.
Filmato video del Palio di Siena del 28 maggio 1950
La scheda completa del Palio Straordinario del 28 maggio 1950
Curiosità
Contesto e organizzazione
Questo Palio Straordinario fu il decimo del Novecento e si caratterizzò per la presenza di dieci Contrade, con un ordine di ingresso tra i canapi determinato da un nuovo meccanismo ideato dall’artigiano senese Luigi Sprugnoli, che garantiva la segretezza dell’ordine fino all’ultimo momento.
Le Contrade al canape
Tra le contrade partecipanti, l’Istrice era considerata la favorita, grazie alla collaudata coppia formata dal fantino Biondo e dal cavallo Popa. La Lupa, tuttavia, non rimase a guardare e organizzò una strategia anti-Istrice coinvolgendo anche altre contrade, mentre cercava la monta adatta per il suo cavallo Salomè.
La sorpresa del Palio fu la Contrada di Valdimontone, che si presentò con il fantino Fernando Leoni, detto Ganascia, e la cavalla Gaia. Nonostante le difficoltà fisiche di Gaia, Ganascia riuscì a portare avanti una corsa astuta e combattuta, giocando d’astuzia fino all’ultimo. Fu probabilmente in quell'occasione che la famosa Stalla del Valdimontone dette la sua prima prova di grande abilità, perché Gaia non era messa per nulla bene.
La Carriera
La partenza vide un gruppo compatto di Onda, Leocorno e Nicchio, che rimasero in testa fino al primo passaggio alla mossa, dove l’Istrice si rivelò fortissima. Il fantino Ciancone, montando per l’Onda, ostacolò ripetutamente Biondo (Istrice), spezzando il ritmo della Popa e permettendo al Nicchio di prendere la testa, seguito dall’Aquila e dal Leocorno, che però caddero entrambe. Quando sembrava che il Nicchio potesse vincere, il suo cavallo Marco Polo I si stancò, e al terzo San Martino si fecero avanti Lupa e Valdimontone, protagoniste di un duello emozionante.
Ganascia, con Gaia ormai stremata, scelse di cadere per giocare l’ultima carta disperata: nella caduta trascinò con sé anche il fantino della Lupa, Tripolino, mentre Salomè si fermò. Gaia, scossa, continuò a correre e vinse, precedendo Ribolla (Leocorno) e l’Istrice, la cui rimonta fu frenata dagli altri cavalli scossi.
Per Ganascia fu l’ottavo e ultimo trionfo nel Palio, conquistato con un capolavoro di astuzia, mentre Tripolino chiuse con malinconia la sua carriera paliesca. Questo Palio è ricordato anche perché stabilì il nuovo meccanismo per l’assegnazione dei posti al canape, ancora oggi in uso.
Palio storico per tanti motivi
- Primo Palio in cui l'ordine di ingresso ai canapi viene determinato con la fiasca meccanica inventata da Luigi Sprugnoli.
- Ultima corsa disputata da Tripoli Torrini, detto Tripolino: nella Lupa.
- Ultima vittoria per Ganascia, che arriva a piedi sotto il palco dei giudici, sarà l'ultima vittoria: infatti Gaia, il cavallo che montava nel Valdimontone, vincerà scossa.
- Per la prima volta si inizia a cronometrare il tempo della corsa, durata un minuto e ventinove secondi.
Curiosità
- Il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi assistette alla corsa, sottolineando l’importanza nazionale dell’evento.
- Il Palio fu dedicato al V centenario della canonizzazione di San Bernardino da Siena.
- Il meccanismo di assegnazione dei posti al canape, introdotto proprio in questa occasione, è ancora oggi utilizzato nei Palii di Siena.
- I contradaioli vittoriosi del Valdimontone vanno a portare il Drappellone nella chiesa di Sant'Elisabetta della Visitazione, perché trovano chiuso l'Oratorio di San Bernardino. Qui dove si andò a festeggiare gli Straordinari dal Novecento in poi.
Il Palio Straordinario del 28 maggio 1950 fu un evento eccezionale, ricco di emozioni, strategie e colpi di scena, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Palio di Siena.
Filmato video del Palio di Siena del 28 maggio 1950
La scheda completa del Palio Straordinario del 28 maggio 1950
Curiosità
Il video del Palio Straordinario del 28 maggio 1950, dal sito della Contrada di Valdimontone
Il resoconto della visita del Presidente della Repubblica, tratto dal portale storico del Quirinale
Il video di 6 minuti del Palio Straordinario del 28 maggio 1950, tratto dall'Archivio Storico dell'Istituto Luce
Palii non tradizionali e straordinari
Le dediche dei Palii dal secondo dopoguerra a oggi
Tutti i Palii Straordinari
Il resoconto della visita del Presidente della Repubblica, tratto dal portale storico del Quirinale
Il video di 6 minuti del Palio Straordinario del 28 maggio 1950, tratto dall'Archivio Storico dell'Istituto Luce
Palii non tradizionali e straordinari
Le dediche dei Palii dal secondo dopoguerra a oggi
Tutti i Palii Straordinari
archivio.quirinale.it
Portale storico della Presidenza della Repubblica
Il sistema informativo e la digital library consentono un accesso diretto ad archivi, documenti, fotografie, dati, percorsi tematici e risorse digitali che trasmettono la memoria dei Capi dello Stato dell'Italia repubblicana
Luogo sepoltura di San Bernardino
San Bernardino da Siena è sepolto all’interno della Basilica di San Bernardino, situata nel centro storico dell’Aquila, in Abruzzo. Le sue spoglie sono custodite in un monumentale mausoleo rinascimentale, realizzato tra il 1489 e il 1505 da Silvestro dell’Aquila, nella cappella a lui dedicata, la quarta sul lato destro della basilica.
Il corpo del santo è collocato in un’urna lignea argentata e dorata visibile attraverso una grata, mentre il mausoleo stesso rappresenta una delle massime espressioni dell’arte rinascimentale in Abruzzo. La basilica fu costruita appositamente per accogliere le sue spoglie, che furono traslate qui nel 1472 dalla chiesa di San Francesco a Palazzo, sempre all’Aquila.
Il Mausoleo di San Bernardino all'Aquila
https://www.basilicasanbernardino.it/
San Bernardino da Siena è sepolto all’interno della Basilica di San Bernardino, situata nel centro storico dell’Aquila, in Abruzzo. Le sue spoglie sono custodite in un monumentale mausoleo rinascimentale, realizzato tra il 1489 e il 1505 da Silvestro dell’Aquila, nella cappella a lui dedicata, la quarta sul lato destro della basilica.
Il corpo del santo è collocato in un’urna lignea argentata e dorata visibile attraverso una grata, mentre il mausoleo stesso rappresenta una delle massime espressioni dell’arte rinascimentale in Abruzzo. La basilica fu costruita appositamente per accogliere le sue spoglie, che furono traslate qui nel 1472 dalla chiesa di San Francesco a Palazzo, sempre all’Aquila.
Il Mausoleo di San Bernardino all'Aquila
https://www.basilicasanbernardino.it/
Wikipedia
Mausoleo di San Bernardino
Il mausoleo di San Bernardino è il monumento funebre di Bernardino da Siena, situato nell'omonima basilica all’Aquila.
COME AVVIENE IL SORTEGGIO PER LA MOSSA DEL PALIO
Dal Palio Straordinario del 28 maggio 1950 l’ordine alla Mossa – rigorosamente segreto e casuale – viene stabilito con il meccanismo, ideato da Luigi Sprugnoli e consistente in una “fiasca” metallica dotata di una canna traforata, nella quale vengono mescolati e messi celatamente in ordine i barberi di legno recanti i colori delle Contrade partecipanti. (fonte sito CTPS).
Il meccanismo è usato ancora oggi, ma solo a partire dal 1952 questo trovò spazio all’interno del regolamento, e l’attuale art. 85 ne disciplina le modalità di utilizzo.
Il meccanismo si compone di una vasca serbatoio ovoidale dal diametro 6 volte superiore alla cubatura complessiva dei 10 barberi che vi verranno introdotti, e di un tubo a doppia camicia ruotante, munito di 9 finestre tonde, numerate dall’1 al 9, e di una finestra quadrata con il numero 10 che indicherà la rincorsa. Tali finestre hanno il diametro leggermente inferiore a quello del singolo barbero.
Al momento dell’ingresso in Campo della quarta comparsa del corteo storico, sul palco dei Giudici, alla presenza dei Deputati, i Capitani o i loro delegati provvederanno ad introdurre i barberi nella vasca. Terminata l’operazione verrà applicato il tubo e chiusa la doppia camicia, ed una volta mescolati i barberi mediante scuotimento del meccanismo, esso verrà rovesciato consentendo così ai barberi di scorrere lungo il tubo che sarà poi staccato dalla vasca, sigillato con impiombatura per evitare manomissioni, e riposto nella propria cassetta.
Tale operazione sarà ripetuta altre 2 volte per completare le 3 buste. Usciti i cavalli dall’Entrone, una volta che essi avranno raggiunto l’altezza del Casato, i Deputati provvederanno ad aprire la cassetta numero 1, a tagliare lo spago che legava la camicia del tubo e, ruotandola, conosceranno l’ordine stabilito dalla sorte, che verrà immediatamente dettato ad un funzionario comunale presente sul palco dei giudici.
Saranno trascritte 3 copie: una per il mossiere, una che viene consegnata al Sindaco ed è a disposizione di Deputati e Capitani, ed una per il graduato della Polizia Municipale, che oggi resta sul palco, ma che fino a non molti anni fa rimaneva sul tufo e si occupava della chiamata delle contrade. Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla seconda e poi alla terza mossa, le stesse operazioni verrebbero ripetute usando i tubi con il numero 2 ed il numero 3. Se poi, nemmeno queste 2 mosse fossero sufficienti, si utilizzerebbero allora gli ordini invertiti delle precedenti 3 buste.
(testo a cura di Davide Donnini, tratto da OK Siena)
Dal Palio Straordinario del 28 maggio 1950 l’ordine alla Mossa – rigorosamente segreto e casuale – viene stabilito con il meccanismo, ideato da Luigi Sprugnoli e consistente in una “fiasca” metallica dotata di una canna traforata, nella quale vengono mescolati e messi celatamente in ordine i barberi di legno recanti i colori delle Contrade partecipanti. (fonte sito CTPS).
Il meccanismo è usato ancora oggi, ma solo a partire dal 1952 questo trovò spazio all’interno del regolamento, e l’attuale art. 85 ne disciplina le modalità di utilizzo.
Il meccanismo si compone di una vasca serbatoio ovoidale dal diametro 6 volte superiore alla cubatura complessiva dei 10 barberi che vi verranno introdotti, e di un tubo a doppia camicia ruotante, munito di 9 finestre tonde, numerate dall’1 al 9, e di una finestra quadrata con il numero 10 che indicherà la rincorsa. Tali finestre hanno il diametro leggermente inferiore a quello del singolo barbero.
Al momento dell’ingresso in Campo della quarta comparsa del corteo storico, sul palco dei Giudici, alla presenza dei Deputati, i Capitani o i loro delegati provvederanno ad introdurre i barberi nella vasca. Terminata l’operazione verrà applicato il tubo e chiusa la doppia camicia, ed una volta mescolati i barberi mediante scuotimento del meccanismo, esso verrà rovesciato consentendo così ai barberi di scorrere lungo il tubo che sarà poi staccato dalla vasca, sigillato con impiombatura per evitare manomissioni, e riposto nella propria cassetta.
Tale operazione sarà ripetuta altre 2 volte per completare le 3 buste. Usciti i cavalli dall’Entrone, una volta che essi avranno raggiunto l’altezza del Casato, i Deputati provvederanno ad aprire la cassetta numero 1, a tagliare lo spago che legava la camicia del tubo e, ruotandola, conosceranno l’ordine stabilito dalla sorte, che verrà immediatamente dettato ad un funzionario comunale presente sul palco dei giudici.
Saranno trascritte 3 copie: una per il mossiere, una che viene consegnata al Sindaco ed è a disposizione di Deputati e Capitani, ed una per il graduato della Polizia Municipale, che oggi resta sul palco, ma che fino a non molti anni fa rimaneva sul tufo e si occupava della chiamata delle contrade. Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla seconda e poi alla terza mossa, le stesse operazioni verrebbero ripetute usando i tubi con il numero 2 ed il numero 3. Se poi, nemmeno queste 2 mosse fossero sufficienti, si utilizzerebbero allora gli ordini invertiti delle precedenti 3 buste.
(testo a cura di Davide Donnini, tratto da OK Siena)
Consorzio per la Tutela del Palio di Siena
brevestoriapalio
IL 29 MAGGIO 1848 SI SVOLGE LA BATTAGLIA DI CURTATONE E MONTANARA
Una tappa epocale per la Toscana e per l'Italia
Il 29 maggio 1848 si svolse la famosa Battaglia di Curtatone e Montanara, due ridenti piccolissime località in provincia di Mantova, dove ancora oggi troneggia un monumento che ricorda la battaglia (qui la geolocalizzazione del monumento), facente parte della Prima Guerra di Indipendenza, combattuta dai piemontesi contro gli austriaci.
La battaglia ebbe un impatto simbolico enorme, sia nell'opinione pubblica toscana, che in generale per tutti gli italiani (o coloro che si sentivano tali - e a tale proposito, questa cosa è ancora oggi di grande attualità).
Siena ci ha insegnato ad essere contradaioli prima, sì, ma poi Senesi e Toscani e Italiani. Successivamente anche Europei. Proprio l'Amore per la Contrada e il fatto che noi Senesi impariamo fin da bambini a rispettare "l'Altro", proprio in nome della Rivalità Contradaiola, che non è mai distruttiva dell'Altro, ma anzi rispetta l'Avversario, costituisce un tratto essenziale della Senesità e della Tempra delle Donne e degli Uomini Senesi, anche quelli del mondo di oggi.
I due Battaglioni toscani che combatterono la Battaglia di Curtatone e Montanara, con notevoli perdite, provenivano dall'Università di Siena e da quella di Pisa. Tutti giovani studenti, animati dai loro Ideali per la Patria e per la Libertà. Ne è testimonianza che in quasi tutte le città e paesi toscani ci sia un toponimo dedicato alla Battaglia di Curtatone e Montanara. In alcune città toscane ci sono addirittura spesso due strade, di solito attigue o parallele, una dedicata a Curtatone (talvolta chiamata anche Curtatona) e Montanara.
Ad es. Via Curtatone e Via Montanara, o solo Via Curtatone e Montanara o anche solo Via Curtatone, perché Montanara, dacché sappiamo noi è una frazione, località di campagna non delimitata da un centro abitato, mentre Curtatone è proprio un paesino, anche se piccolo. A Montanara la via principale del centro abitato si chiama proprio Via dei Toscani. Se ci capitate, andate a vederla. Qui la geolocalizzazione della strada.
Sebbene non grandi per proporzioni belliche, i due battaglioni toscani ebbero un notevole significato dal punto di vista tattico per aver ritardato l'avanzata degli Austriaci sul campo di battaglia di circa 8 ore. Ciò assunse un'importanza strategica fondamentale, in vista della Battaglia di Goito, che si svolse il giorno successivo e che vide la prima grande Vittoria dei Piemontesi.
Un paio di mesi fa ne abbiamo parlato per ricordate la partenza dei battaglioni toscani, che andarono a piedi partendo da Siena e poi, passando da Pistoia e Porretta si avviarono verso l'Appennino, con il punto di raccolta in località La Lima, all'Abetone (provenienti sostanzialmente dalle due università di Pisa e di Siena), mentre gli studenti da Pisa, sempre a piedi, percorrevano la SS12 del Brennero.
A futura memoria oggi sono 177 anni da quei gloriosi eventi. Onore ai caduti Toscani.
Questi episodi ci ricordano che gli ideali per un mondo migliore contano più di ogni cosa e ad essi vale la pena sacrificare persino la propria vita di giovani uomini di poco più che venti anni.
A Siena Via Curtatone si trova nella Contrada del Drago, ecco la geolocalizzazione. Tuttavia è solo una coincidenza se la Contrada di Camporegio festeggia la sua Festa Titolare proprio il 29 maggio di ogni anno, cioè il giorno dell'anniversario della Battaglia, perché in realtà la data del 29 maggio è legata a Santa Caterina da Siena, la santa patrona della Contrada.
Una tappa epocale per la Toscana e per l'Italia
Il 29 maggio 1848 si svolse la famosa Battaglia di Curtatone e Montanara, due ridenti piccolissime località in provincia di Mantova, dove ancora oggi troneggia un monumento che ricorda la battaglia (qui la geolocalizzazione del monumento), facente parte della Prima Guerra di Indipendenza, combattuta dai piemontesi contro gli austriaci.
La battaglia ebbe un impatto simbolico enorme, sia nell'opinione pubblica toscana, che in generale per tutti gli italiani (o coloro che si sentivano tali - e a tale proposito, questa cosa è ancora oggi di grande attualità).
Siena ci ha insegnato ad essere contradaioli prima, sì, ma poi Senesi e Toscani e Italiani. Successivamente anche Europei. Proprio l'Amore per la Contrada e il fatto che noi Senesi impariamo fin da bambini a rispettare "l'Altro", proprio in nome della Rivalità Contradaiola, che non è mai distruttiva dell'Altro, ma anzi rispetta l'Avversario, costituisce un tratto essenziale della Senesità e della Tempra delle Donne e degli Uomini Senesi, anche quelli del mondo di oggi.
I due Battaglioni toscani che combatterono la Battaglia di Curtatone e Montanara, con notevoli perdite, provenivano dall'Università di Siena e da quella di Pisa. Tutti giovani studenti, animati dai loro Ideali per la Patria e per la Libertà. Ne è testimonianza che in quasi tutte le città e paesi toscani ci sia un toponimo dedicato alla Battaglia di Curtatone e Montanara. In alcune città toscane ci sono addirittura spesso due strade, di solito attigue o parallele, una dedicata a Curtatone (talvolta chiamata anche Curtatona) e Montanara.
Ad es. Via Curtatone e Via Montanara, o solo Via Curtatone e Montanara o anche solo Via Curtatone, perché Montanara, dacché sappiamo noi è una frazione, località di campagna non delimitata da un centro abitato, mentre Curtatone è proprio un paesino, anche se piccolo. A Montanara la via principale del centro abitato si chiama proprio Via dei Toscani. Se ci capitate, andate a vederla. Qui la geolocalizzazione della strada.
Sebbene non grandi per proporzioni belliche, i due battaglioni toscani ebbero un notevole significato dal punto di vista tattico per aver ritardato l'avanzata degli Austriaci sul campo di battaglia di circa 8 ore. Ciò assunse un'importanza strategica fondamentale, in vista della Battaglia di Goito, che si svolse il giorno successivo e che vide la prima grande Vittoria dei Piemontesi.
Un paio di mesi fa ne abbiamo parlato per ricordate la partenza dei battaglioni toscani, che andarono a piedi partendo da Siena e poi, passando da Pistoia e Porretta si avviarono verso l'Appennino, con il punto di raccolta in località La Lima, all'Abetone (provenienti sostanzialmente dalle due università di Pisa e di Siena), mentre gli studenti da Pisa, sempre a piedi, percorrevano la SS12 del Brennero.
A futura memoria oggi sono 177 anni da quei gloriosi eventi. Onore ai caduti Toscani.
Questi episodi ci ricordano che gli ideali per un mondo migliore contano più di ogni cosa e ad essi vale la pena sacrificare persino la propria vita di giovani uomini di poco più che venti anni.
A Siena Via Curtatone si trova nella Contrada del Drago, ecco la geolocalizzazione. Tuttavia è solo una coincidenza se la Contrada di Camporegio festeggia la sua Festa Titolare proprio il 29 maggio di ogni anno, cioè il giorno dell'anniversario della Battaglia, perché in realtà la data del 29 maggio è legata a Santa Caterina da Siena, la santa patrona della Contrada.
Ecco il programma della festa titolare della Imperiale Contrada della Giraffa dedicata alla Visitazione di Maria Santissima
https://contradadellagiraffa.com/programma-festa-titolare-2025/
#festatitolare #imperialecontradadellagiraffa
https://contradadellagiraffa.com/programma-festa-titolare-2025/
#festatitolare #imperialecontradadellagiraffa
Contrada della Giraffa
Programma Festa Titolare 2025 - Contrada della Giraffa
FESTA TITOLARE IN ONORE DELLA VISITAZIONE DI MARIA SANTISSIMA DELLA IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA
Andiamo a rivedere il bellissimo documentario "Contrada è..." a cura di Andrea Sbardellati e dedicato alla Contrada della Giraffa.
Durata: 34' 02"
#giraffa #imperialecontradadellagiraffa #festatitolaregiraffa #festatitolare #contradaè
Andiamo a rivedere il bellissimo documentario "Contrada è..." a cura di Andrea Sbardellati e dedicato alla Contrada della Giraffa.
Durata: 34' 02"
#giraffa #imperialecontradadellagiraffa #festatitolaregiraffa #festatitolare #contradaè
YouTube
Contrada E' (Giraffa)
Un programma a cura di Andrea Sbardellati ed Enza Pipitone
Ricordo che la Imperiale Contrada della Giraffa ha pubblicato sul sito ufficiale di Contrada anche i recapiti per visitare il Museo
Informazioni per visite al Museo
(+39) 338 2334380
[email protected]
Informazioni per visite al Museo
(+39) 338 2334380
[email protected]
La Contrada di Provenzano Salvani si distingue per tre titoli importanti, ottenuti in occasioni legate a momenti storici dell’Italia.
La Giraffa è detta "Reale", perché ha vinto il Palio del 16 luglio 1887, alla presenza del Re Umberto I e della Regina Margherita di Savoia.
Il titolo di "Imperiale" arriva dalla vittoria del Palio del 2 luglio 1936, quando si festeggiava la nascita dell’Impero Italiano e c’erano presenti a quel Palio Re Vittorio Emanuele III e la Regina Elena.
Il titolo di "Repubblicana" è stato dato dopo la vittoria al Palio del 16 agosto 1946, alla presenza del Capo Provvisorio della Repubblica, Enrico De Nicola.
Nel 1946 è stata pubblicata una rivista speciale chiamata proprio "Reale, Imperiale, Repubblicana" per celebrare questa particolarità della Giraffa.
Oggi però, la Contrada usa ufficialmente solo il titolo di "Imperiale".
A suggello di questo titolo di "Repubblicana", il Museo della Giraffa è sempre aperto il 2 giugno alle visite.
https://www.tg-me.com/paliodisiena/7688
La Giraffa è detta "Reale", perché ha vinto il Palio del 16 luglio 1887, alla presenza del Re Umberto I e della Regina Margherita di Savoia.
Il titolo di "Imperiale" arriva dalla vittoria del Palio del 2 luglio 1936, quando si festeggiava la nascita dell’Impero Italiano e c’erano presenti a quel Palio Re Vittorio Emanuele III e la Regina Elena.
Il titolo di "Repubblicana" è stato dato dopo la vittoria al Palio del 16 agosto 1946, alla presenza del Capo Provvisorio della Repubblica, Enrico De Nicola.
Nel 1946 è stata pubblicata una rivista speciale chiamata proprio "Reale, Imperiale, Repubblicana" per celebrare questa particolarità della Giraffa.
Oggi però, la Contrada usa ufficialmente solo il titolo di "Imperiale".
A suggello di questo titolo di "Repubblicana", il Museo della Giraffa è sempre aperto il 2 giugno alle visite.
https://www.tg-me.com/paliodisiena/7688
Telegram
Il Palio di Siena 🏇
Ricordo che la Imperiale Contrada della Giraffa ha pubblicato sul sito ufficiale di Contrada anche i recapiti per visitare il Museo
Informazioni per visite al Museo
(+39) 338 2334380
[email protected]
Informazioni per visite al Museo
(+39) 338 2334380
[email protected]